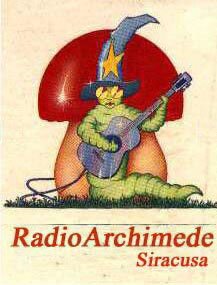
| Dopo nove lunghi anni di indagini,
segnati da continui imprevisti, difficoltà e richieste di proroghe,
la procura di Brescia depositerà finalmente nelle prossime settimane,
passato il 32° anniversario, gli atti per un nuovo rinvio a giudizio
nei confronti
di tre neofascisti per la strage del 28 maggio 1974 in Piazza della Loggia. Nel caso la richiesta fosse accolta si aprirebbe un ennesimo processo, dopo quattro istruttorie e due iter giudiziari, conclusisi, fra il 1979 e il 1989, con un nulla di fatto. L’unica condanna fu in primo grado, il 2 luglio 1979, nei confronti di Ermanno Buzzi (all’ergastolo) e Angelino Papa (dieci anni e sei mesi). Buzzi, alla vigilia del processo d’appello, dopo aver dichiarato di “voler parlare”, fu assassinato, il 13 aprile del 1981, nel “super-carcere” di Novara, a nemmeno quarantotto ore dal suo arrivo dall’istituto penitenziario di Brescia, su disposizione del Ministero di grazia e giustizia. A strangolarlo nel cortile, durante l’ora d’aria, Mario Tuti e Pierluigi Concutelli, due fra i massimi esponenti del terrorismo nero. La sua sentenza di morte era stata pubblicata il mese precedente su “Quex”, il foglio di collegamento dei neofascisti incarcerati, stampato a Parigi con l’aiuto di neonazisti francesi, e fatto circolare nello stesso carcere di Novara. Difficile pensare che chi ordinò il suo trasferimento ne fosse totalmente all’oscuro. |
LA STRAGE
La mattina del 28 maggio 1974 a Brescia, sotto un
cielo cupo e piovoso, alle 10 e 12 minuti, nel corso di uno sciopero generale
cittadino di quattro ore, indetto da Cgil, Cisl e Uil, congiuntamente al
Comitato permanente antifascista, in risposta alle ripetute violenze fasciste,
mentre in Piazza della Loggia da pochi minuti stava parlando il sindacalista
della Cisl Franco Castrezzati, scoppiò una bomba posta in un cestino
per i rifiuti, sul lato est, sotto i portici. I morti furono 8 e 103 i
feriti. La piazza era già colma di gente, più di 2.500 le
persone presenti, ancora in attesa di due dei quattro cortei previsti.
Incerta rimase sempre la natura e la quantità
dell’esplosivo. Accadde infatti che alle 11,45, a poco più di un’ora
e mezza dallo scoppio, senza nemmeno attendere l’arrivo del magistrato
incaricato, la piazza venne lavata dai vigili del fuoco con pompe idranti,
su decisione della questura, disperdendo i reperti dell’ordigno esplosivo.
A nulla false una successiva ricerca nelle fogne.
Ancor prima, nessuno, quella mattina, si era dato
pensiero di controllare le cassette metalliche portarifiuti distribuite
nelle piazza e sotto i portici, nonostante le forze di polizia sostassero
fin dalle 8,30. I netturbini, dal canto loro, avevano provveduto al loro
svuotamento tra le 6,45 e le 7,00. Solo il palco era stato controllato
dal vice-questore Aniello Diamare, incaricato di dirigere il servizio di
ordine pubblico.
Eppure una serie impressionante di attentati aveva
colpito, nei mesi precedenti, la Lombardia, l’Emilia e la Toscana. Il 28
marzo in Piazza Maspero a Varese lo scoppio di un ordigno aveva ucciso,
poco prima dell’apertura del mercato, un ignaro fiorista, e, proprio a
Brescia, il 19 maggio Silvio Ferrari, un giovane neofascista, era saltato
in aria con il suo scooter mentre trasportava una bomba ad alto potenziale.
Silvio Ferrari, figlio di una famiglia agiata, era
già a 21 anni un esponente di primo piano dell’estrema destra bresciana.
Aveva avuto legami con Anno zero, la reincarnazione di Ordine nuovo dopo
il suo scioglimento nel 1973. Diverse le sue amicizie anche fra i sanbabilini.
Rimase dilaniato, in Piazza del Mercato, alle tre
e cinque di notte, dallo scoppio di una bomba che, in previsione di un
altro attentato, stava trasportando sulla pedana della Vespa 125 “Primavera”
del fratello Mauro. L’ordigno era composto da un chilo di tritolo e da
nitrato di ammonio, già con il detonatore elettrico innescato ed
il congegno ad orologeria. Sul suo corpo, alla cintura, venne ritrovata
una fondina vuota e a tre metri una Beretta 7,65 con caricatore e il proiettile
in canna. A poca distanza alcune copie bruciacchiate della rivista “Anno
Zero”.
Nella stessa notte, quasi contemporaneamente, un auto,
targata Milano, con quattro fascisti a bordo finì inspiegabilmente
schiantata contro un muro all’angolo fra Via Villa Glori e Via Milano.
Il guidatore morì. Anche in questa circostanza nell’auto furono
ritrovate copie di “Anno Zero”.
Ai funerali di Silvio Ferrari, comparve, a firma “I
camerati”, una corona di fiori con l’ascia bipenne, simbolo prima di Ordine
nuovo, poi di Ordine nero.
Sarà proprio a seguito della sua morte che,
il 22 maggio, il Comitato permanete antifascista e Cgil, Cisl e Uil, nel
quadro dell’escalation terroristica e delle indagini sul Mar (il Movimento
di azione rivoluzionaria), indiranno lo sciopero generale cittadino.
IL “PARTITO DEL GOLPE”
Solo qualche giorno prima la bomba di Piazza della
Loggia, il 9 maggio, i capi del Mar erano stati arrestati alla vigilia
di un piano di attentati a tralicci, porti e aeroporti, previsto in diverse
città, tra le altre, Roma, Genova e Firenze. Sullo sfondo l’intreccio
tra l’anticomunismo “bianco” animato da Edgardo Sogno, con l’appoggio di
settori delle Forze Armate, e l’eversione neofascista coagulatasi attorno
ad Ordine nero, la nuova sigla nella quale erano confluite le principali
organizzazioni terroristiche, da Avanguardia nazionale alle Sam (le Squadre
d’azione Mussolini) Mesi prima il giudice padovano Giovanni Tamburino aveva
scoperto le trame della cosiddetta “Rosa dei Venti”, dal simbolo utilizzato
da una costellazione articolata di gruppi neofascisti identico a quello
della Nato.
Due giorni dopo la strage, il 30 maggio, alle 7 del
mattino, a Pian del Rascino, in provincia di Rieti, nel corso di una sparatoria,
due guardie forestali e cinque carabinieri guidati dal maresciallo, nonché
agente del Sid, Antonio Filippi, uccisero Giancarlo Esposti, 27 anni, uno
dei principali esponenti di Ordine nero, il braccio armato del Mar, accampato
in una radura.
La dinamica del conflitto a fuoco non venne mai chiarita.
Il corpo di Esposti fu ritrovato crivellato di colpi e finito con un colpo
alla testa. Furono nell’occasione tratti in arresto Alessandro D’Intino
e Alessandro Danieletti, di 21 e 20 anni, legati ad Avanguardia nazionale.
Nella Land Rover un fucile di precisione Hammerling
Mauser, calibro 7,62 Nato, due mitra, pistole, munizioni, una grossa quantità
di esplosivo, tra cui 50 chilogrammi di Anfo, centinaia di detonatori.
Nelle tasche di Esposti una tessera della Pide, la polizia politica portoghese
appena sciolta dopo la “rivoluzione dei garofani”, una tessera da studente
della Sorbona, un’agendina e due foto formato tessera di Cesare Ferri,
notissimo neofascista milanese.
Carlo Fumagalli, il capo del Mar, chiarirà
che l’obiettivo era di arrivare a tentare un colpo di stato, con l’aiuto
di nuclei terroristici. Teatro delle operazioni la Valtellina, ma anche
il centro Italia. Il gruppo di Esposti si trovava in Abruzzo in attesa
di un’azione che avrebbe dovuto fungere da detonatore per l’entrata in
azione sua e di gruppi analoghi.
Alessandro Danieletti confesserà che la prospettiva
golpista si sarebbe dovuta attuare attraverso “una serie di attentati di
gravità crescente”, di stragi indiscriminate in città diverse.
Sosterrà anche che la missione del gruppo, di cui faceva parte,
prevedeva un attentato a Roma, il 2 giugno, in occasione della festa della
Repubblica.
Il commando si era mosso da Milano subito dopo l’arresto,
il 9 maggio, di Carlo Fumagalli. Secondo D’Intino il piano originario,
che prevedeva attentati a raffinerie, linee ferroviarie e dighe, sarebbe
dovuto scattare proprio il 28.
Colpire tra la folla per seminare il terrore rientrava
nei piani dei settori golpisti delle Forze Armate e della destra eversiva,
per precipitare il paese nell’abisso di una “guerra civile” o condurlo
ad una svolta autoritaria. In quegli anni furono particolarmente presi
di mira i treni. Solo sul tratto, di cento chilometri, che collega Arezzo,
la città di Licio Gelli, a Bologna, tra il 21 aprile del 1974 e
il 7 gennaio del 1975, si consumò una strage, quella del 4 agosto
del 1974 con una bomba sul treno “Italicus” (12 morti e 44 feriti), mentre
sei altri diversi tentativi andarono a vuoto per un nonnulla. Una linea
“maledetta” ancora teatro, negli anni a venire, di spaventosi eccidi: il
2 agosto 1980 alla stazione di Bologna e il 23 dicembre del 1984 sul rapido
Napoli-Milano.
L’ULTIMA INCHIESTA
Due le testimonianze principali che hanno accompagnato
l’ultimo lavoro di indagine dei sostituti procuratori di Brescia Roberto
Di Martino e Francesco Piantoni: quella di Carlo Digilio, l’ex-artificiere
di Ordine nuovo, già alla base con i suoi racconti del procedimento
su Piazza Fontana, e quella di Maurizio Tramonte.
A fornire l’esplosivo sarebbe stato Delfo Zorzi. Marcello
Soffiati, capocellula di Verona, deceduto anni fa, lo avrebbe trasportato.
Lo stesso Digilio, in una tappa del percorso, si sarebbe occupato di mettere
l’ordigno “in sicurezza”, impedendo che deflagrasse inavvertitamente lungo
il tragitto. A Milano fu consegnato alle Sam di Giancarlo Esposti, materialmente
incaricate di compiere la strage.
Secondo Maurizio Tramonte fu invece Giovanni Melioli,
il capo degli ordinovisti di Rovigo a collocare l’esplosivo. Per la cronaca,
Melioli venne rinvenuto morto nel suo letto, nel gennaio del 1991, con
mezzo chilo di cocaina sul comodino. Un racconto che se si discosta da
quello di Carlo Digilio, si sofferma con dovizia di particolare sulle riunioni
preparatorie, ma soprattutto sul ruolo di Carlo Maria Maggi, su quello
degli esponenti del Mar di Carlo Fumagalli e di alcuni agenti dei servizi
segreti, oltre che di Ermanno Buzzi, il neofascista bresciano condannato
all’ergastolo nel primo processo.
Ma di gran lunga l’elemento più interessante
è un altro. Agli atti i magistrati allegheranno una fotografia scattata
in Piazza della Loggia qualche istante prima lo scoppio della bomba. Confuso
tra la folla, con un’attendibilità di riconoscimento, secondo i
tecnici, molto alta, attorno al 92 per cento, lo stesso Maurizio Tramonte,
la “fonte Tritone” del Sid. Una presenza che riporta alla mente la deposizione
di una donna di mezza età, presente quel giorno al comizio, che
testimoniò di aver occasionalmente sentito, pochi minuti prima della
deflagrazione, cercando riparo dalla pioggia sotto i portici, un dialogo
sussurrato fra due giovani. Uno disse all’altro: “Hai pronto la bomba?”.
Li perse quasi subito di vista tra la folla.
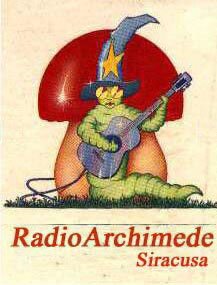 |