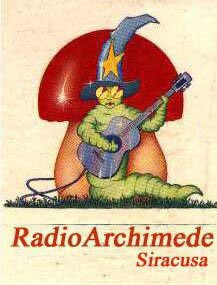
Tutto comincia negli anni '90 mediante un esposto del dott. Enrico Fontana (all'epoca un responsabile dei Centri di Azione Giuridica di Legambiente) presso la Procura di Reggio Calabria indicante i sospetti del traffico di rifiuti tossici tra le regioni del nord e la Calabria. Iniziavano le indagini che venivano affidate al dott. Francesco Neri, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica della Pretura di Reggio Calabria.
La grande preparazione del dott. Neri, le informazioni fornite dalla Legambiente e la presenza di alcune famiglie calabresi consentivano di tracciare velocemente i primi collegamenti tra le varie regioni e gli intrecci relativi al traffico dei rifiuti.
Dopo mesi di indagini veniva fuori un quadro inquietante, tanto che i giornali nazionali, per diverse settimane, parlavano di coste a rischio e contaminate.
L'inchiesta subiva un brusco arresto, in quanto il Ministero non dava alla Procura di Reggio Calabria l'autorizzazione ad eseguire una perizia tecnica sulle navi, che risultavano affondate dinanzi a Capo Spartivento, in una frattura del terreno, ove la profondità marina era rilevantissima.
Da voci di corridoio sembrerebbe che l'indagine avesse raggiunto livelli molto alti e che il traffico si riferisse a scorie nucleari, oltre che ai rifiuti tossici. In sostanza, sembrerebbe, che dei calabresi emigrati in Liguria abbiano cominciato, circa venti anni fa, ad interessarsi di rifiuti e che nello spazio di pochi anni abbiano costruito una fortuna ingente. Quando, nella terra ligure i problemi sono diventati tanti, per le indagini assunte dalla magistratura del luogo, i suddetti personaggi trasferivano i loro interessi nelle altre regioni del nord Italia, continuando dapprima il traffico con i rifiuti tossici e poi, successivamente, interessandosi di quelli nucleari. In tale traffico venivano individuati anche possibili responsabilità di alcuni governi europei che affidavano le scorie radioattive ad una società, che si impegnava alla loro eliminazione tramite l'inserimento di queste in tubi di acciaio, che poi dovevano essere conficcati - secondo i contratti - a grandi profondità nel terreno.
Sembrerebbe, invece, che tali scorie venivano consegnate a dei clan mafiosi che provvedevano a caricarle su delle vecchie navi, con l'indicazione di trasporto di polvere di marmo, e, dopo una sosta a Livorno, venivano affondate nel Mediterraneo. L'inchiesta, in considerazione dei personaggi e delle questioni trattate, venne poi trasmessa per competenza alla Procura Distrettuale Antimafia. [1]
--------------------------------------------------------------------------------
fonti:
[1] http://www.sosed.it/Cdsole/LugAgo99/E9-799.htm
[2] http://notes3.senato.it/ODG_PUBL.NSF/0/f86e432a734df2a74125686c00384d03?OpenDocument
[3] http://www.regione.basilicata.it/osservatorioambiente/default.cfm?dir=45&doc=161&fuseaction=doc
[4] http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenografici/sed491/aurg01.htm
[5] http://www.edilitaly.com/ambiente/rapanpa.htm
[6] http://www.sinanet.apat.it/aree/Radiazioni%20ionizzanti/Radioattivit%C3%A0%20Artificiale/RappCal.asp
[7] http://www.parlamento.it/parlam/bicam/rifiuti/Sedute/02.htm
[8]Articolo del settimanale cartaceo "L'Espresso" del 9 settembre 2004, pag.34 e successive
("Naufragio radioattivo" di Riccardo Bocca)
[9]Articolo del settimanale cartaceo "L'Espresso" del 16 settembre 2004, pag.76 e successiva
("Indagini Radioattive" colloquio con Paolo Russo di Riccardo Bocca)
[10]Articolo del settimanale cartaceo "L'Espresso" del 23 settembre 2004, pag.76 e successiva
("Nella memoria si è aperta una falla" colloquio con Gianfranco Messina di Riccardo Bocca)
--------------------------------------------------------------------------------
A. Le inchieste e le indagini avviate dalle Procure negli anni '90
La "Commissione monocamerale d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti" istituita presso la Camera dei Deputati nella XII legislatura [15 aprile 1994 - 16 febbraio 1996] ebbe ad occuparsi del preoccupante fenomeno dei traffici e degli smaltimenti illegali di scorie e rifiuti radioattivi in mare, nell’ambito di alcune inchieste avviate dalle procure di Matera, Reggio Calabria e Napoli relative all’affondamento di navi che si sospetta fossero cariche di scorie e rifiuti radioattivi, principalmente nel mar Mediterraneo, cui si accompagnava la consumazione di una serie di truffe alle compagnie assicurative con la riscossione dei premi previsti per i sinistri marittimi.
Secondo la ricostruzione offerta dagli organi inquirenti il progetto prevedeva il lancio dalle navi di penetratori caricati con scorie radioattive, racchiuse in contenitori di acciaio inossidabile dotati di sistema sonar (sì da renderli rilevabili ai fini di un eventuale recupero), che si depositavano sino a 50-80 metri al di sotto del fondale marino; in alternativa, si affondava la nave con l’intero carico pericoloso, simulando un affondamento accidentale e lucrando, così, anche del premio assicurativo.
Nell’ambito del fenomeno che si è descritto, l’inchiesta di maggiore interesse rimane quella avviata dall’ufficio di procura della pretura di Reggio Calabria e poi trasmigrata per competenza alla locale procura distrettuale antimafia [nel 1996], anche in considerazione degli elementi che essa ha offerto sulle relazioni con presunti traffici illegali di armi su scala internazionale, che hanno determinato l’avvio di ulteriori indagini, tuttora pendenti, presso le procure competenti di Milano e Brescia.
L’indagine calabrese, avviata nel 1994, ha per oggetto alcuni affondamenti sospetti di navi nel Mediterraneo, al largo delle coste ioniche calabresi (le cosiddette «navi a perdere», utilizzate per l’affondamento di rifiuti radioattivi), in particolare quello della motonave Rigel, che sarebbe affondata il 21 settembre 1987 a 20 miglia da Capo Spartivento, e vede in ruolo chiave tale Giorgio Comerio personaggio in contatto con noti trafficanti di armi e coinvolto anche nella fabbricazione di telemine destinate a diversi paesi, come l’Argentina. L’organo inquirente ha prospettato la partecipazione di clan della ndrangheta a siffatti smaltimenti illeciti, motivo per cui si è radicata la competenza nell’ufficio distrettuale.
A prescindere dagli esiti strettamente processuali del procedimento penale pendente a Reggio Calabria, permane la più viva preoccupazione per tutta una serie di elementi offerti dalla stessa indagine e dagli altri dati acquisiti.
Anzitutto, va evidenziato che gli accertamenti condotti dagli investigatori unitamente all’ANPA, tendenti alla localizzazione e al recupero della motonave in Rigel, nonché al rilevamento della presenza dei rifiuti radioattivi in mare, se pure hanno dato esiti infruttuosi muovevano, però, da coordinate geografiche assai incerte circa il luogo del presunto affondamento della nave e dalle oggettive difficoltà delle operazioni di rilevamento della presenza di rifiuti radioattivi in navi affondate in tratti di mare con fondali particolarmente profondi. La grande profondità dei fondali marini esplorati e la loro sconnessione, d’altra parte, vanificavano in sostanza l’attività di rilevamento con la strumentazione radiometrica, poiché questa, a causa della pressione marina, avrebbe potuto individuare la presenza di radioattività solo in prossimità estrema al relitto.
È evidente che tale incertezza dei dati ha compromesso il percorso dell’indagine e la correttezza dei suoi esiti, non contribuendo di certo a fugare seri dubbi sulla natura quantomeno pericolosa del carico portato dalla Rigel, attese le «strane» circostanze del suo affondamento e la provenienza di parte del carico che essa portava.
Infatti, secondo i giornali di bordo, la motonave sarebbe affondata a causa di un’infiltrazione d’acqua nel motore, ma il consulente del PM ha contestato che ciò solo poteva portare all’affondamento e, tanto meno, creare una situazione di pericolo tale da giustificare l’immediato abbandono da parte dell’equipaggio senza l’avvio delle usuali azioni intese ad ottenere l’intervento di rimorchiatori o altri mezzi di soccorso per tentare il salvataggio della nave e del suo carico.
Altro dato particolarmente interessante evidenziato dalla consulenza è che gran parte delle merci ufficialmente caricate sulla Rigel proveniva da ditte in difficoltà economica; talune partite erano rappresentate da merci (materiali – macchinari) fuori produzione o di recupero per i quali mancava la dovuta congruità tra valore assicurato e valore effettivo, come del resto dimostrato nel procedimento per truffa aggravata ai danni delle assicurazioni svoltosi presso il tribunale della Spezia, che si è concluso con la condanna degli imputati per avere, appunto, organizzato l’affondamento al fine di lucrare dei premi assicurativi dal sinistro.
Non può, dunque, escludersi che alcuni caricatori consapevoli abbiano caricato anche prodotti pericolosi, specie se si tiene conto di alcune merci particolarmente sospette, che ben avrebbero potuto celare scorie tossiche. Inquietanti sono, poi, gli elementi di analogia tra l’affondamento della Rigel ed altri affondamenti di motonavi, che la consulenza pone in rilievo.
Ben 39, infatti, risultano i casi di affondamento di navi riferiti al mar Ionio, verificatisi tra il 1979 ed il 1995, dati tratti dall’archivio STB Italia di Genova e Milano, e da varie compagnie assicurative, fra cui la Lloyd’s Register of Shipping, sede di Genova. In particolare, va ricordato l’affondamento della motonave «Barbara» ,avvenuto nei pressi dell’isola Zante il 26 giugno 1982, che presenta aspetti del tutto simili a quello della Rigel: la nave, che portava un carico di manganese in fusti (circa 1200 tonnellate), presso l’isola di Zante pativa una infiltrazione d’acqua nel motore ed il progressivo allagamento che determinava il suo abbandono da parte dell’equipaggio. È risultato però che la nave, mentre era ferma nel porto della Spezia, era stata urtata da un’altra motonave battente bandiera greca, ma – fatto davvero strano – non era stata avvisata dal comandante né la locale capitaneria di porto né il Registro italiano navale.
Insomma, il carico di minerali in fusti, la rotta seguita, la circostanza che a La Spezia non sia stato dato alcun avviso dell’incidente occorso a tutela degli stessi interessi armatoriali ed ai fini della convalida della classe della nave, rende la vicenda certamente sospetta.
Vi è poi la motonave «Rosso», incagliatasi il 14 dicembre 1990 nei pressi di Vibo Valentia ed abbandonata dall’equipaggio, la quale – quando era ancora denominata «Jolly Rosso» – era stata utilizzata dal Governo italiano per il trasporto di 2.200 tonnellate di rifiuti tossici dal Libano alla Spezia; dopo che i rifiuti erano stati scaricati, la nave veniva bonificata; successivamente l’armatore ne modificava la denominazione e la metteva in vendita, e subito dopo si verificava l’incaglio a Vibo Valentia.
Ancora: si rammenti la vicenda relativa all’affondamento della motonave «Marco Polo», già affrontata dalla precedente Commissione ed oggetto di indagine da parte della stessa Procura presso la pretura di Reggio Calabria, verificatosi nel mese di maggio 1993 all’altezza del Canale di Sicilia. In questo caso, si è riscontrata la presenza di radioattività da torio 234 su campioni di alghe e materiale ferroso prelevati a seguito del rinvenimento in mare (nell’aprile 1994), al largo delle coste della Campania, di alcuni containers persi dalla citata nave.
Notevoli sono le analogie di questo affondamento con quello della motonave Koraline, avvenuto al largo di Ustica (sono stati, infatti, rinvenuti anche in questo caso alcuni containers con la presenza di forti concentrazioni di torio).
Merita ancora segnalare la sparizione della motonave «Nicos 1» e del suo carico: nel periodo 3 luglio 1985– 16 novembre 1985, mentre essa caricava nel porto della Spezia, ne veniva arrestato il comandante e disposto il sequestro conservativo e del carico e della stessa motonave; quando, infine, riusciva a partire, dichiarava quale porto di destinazione quello di Lomè (Togo) dove non è mai arrivata, ed anzi risulta che avrebbe scalato in porti assolutamente fuori rotta (Cipro, Libano, Grecia). Secondo la documentazione ufficiale, i caricatori erano rappresentati da alcune ditte italiane per materiali vari (come legname, contenitori di metallo, macchine per la lavorazione del legno, sanitari, fotoriproduttori) che erano stati imballati in containers, gabbie e cartoni. A fronte di siffatte circostanze quantomeno anomale, si ritiene, invece, che la motonave in oggetto, una volta sbarcato il carico in Libano e sostituito il personale di bordo, abbia cambiato denominazione («Haris») per essere rintracciata in porto greco.
Ancora, l’affondamento della motonave «Alessandro I», avvenuto il Iº febbraio del 1991 nei pressi di Molfetta, attribuito dall’autorità marittima ad «imperizia» del Comandante, mentre i dati tecnici consentirebbero di affermare che la stabilità della nave fosse tale che essa era predisposta alla possibilità di «ingavonamento» e, comunque, la causale del sinistro non potrebbe farsi dipendere dalla sola imperizia del comandante. In ogni caso, la parte più inquinante del carico portato dalla motonave è stata recuperata.
Ebbene, il numero, la natura e le forti analogie dei casi interessati al fenomeno delle cd. «navi a perdere» rendono del tutto probabile l’ipotesi, tuttora non suffragata da idonei riscontri, che la Rigel e le altre motonavi portassero carichi di merci quantomeno pericolose, se non di rifiuti radioattivi. [2]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Le inchieste e le indagini avviate dalle Procure negli anni '90
I traffici internazionali via mare di rifiuti pericolosi anche radioattivi e la prima inchiesta giornalistica de "L'Espresso"
Il monitoraggio della radioattività lungo le coste della Calabria e Basilicata
Gli ultimi avvenimenti e la nuova inchiesta giornalistica de "L'Espresso" del 9, 16 e 23 settembre 2004
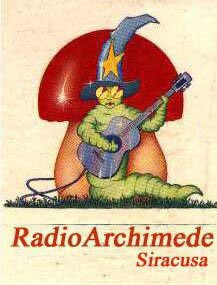 |