

Il 12 dicembre 1969, alle ore 16.30, la Banca Nazionale dell’Agricoltura sita in Piazza Fontana a Milano, è lacerata dallo scoppio di un ordigno che causa la morte di 16 persone e il ferimento di altre 88. Quello stesso giorno nella sede milanese della Banca Commerciale Italiana, in Piazza della Scala, viene scoperta una bomba inesplosa. Sempre il 12 dicembre esplodono a Roma altri tre ordigni con un bilancio approssimativo di 17 feriti. Nelle ore successive agli attentati sono perquisite le sedi di tutte le organizzazioni anarchiche e dell’estrema sinistra, le quali porteranno agli arresti dei militanti del gruppo anarchico 22 Marzo tra le cui fila compaiono Mario Merlino, Giuseppe Pinelli e Pietro Valpreda. Pinelli morirà tre giorni più tardi cadendo da una finestra della questura di Milano, dove gli uomini del commissario Calabresi lo stavano interrogando. La sua morte verrà archiviata come un suicidio. Valpreda sarà invece riconosciuto come l’esecutore materiale della strage di Piazza Fontana sulla testimonianza di Mario Merlino e di un tassista semi alcolizzato che afferma di aver condotto personalmente il Valpreda sul luogo della strage.
Nel frattempo a Padova un commerciante dichiara ai Carabinieri che le borse degli attentati, alcune delle quali ritrovate ancora con le etichette del negozio, erano state vendute presso il suo esercizio la sera del 10 dicembre; il verbale della sua testimonianza è datato 15 dicembre 1969 ed è inviato il giorno stesso alla questura di Milano, di Roma e al Ministero degli Interni, ma qualcuno si occupa di farla sparire immediatamente. Alcuni anni più tardi viene accusato di “intralcio alla giustizia” il vice capo della Polizia di Milano Elvio Catenacci.
La sera del 15 dicembre 1969, Guido Lorenzon, segretario di una sezione della DC di Treviso si presenta ad un magistrato della città dichiarando di essere a conoscenza di fatti che sono in relazione con gli attentati. Lorenzon conosce l’editore Giovanni Ventura e l’avvocato Franco Freda, entrambi militanti nel gruppo neofascista di Ordine Nuovo, ex esponenti del FUAN (l’organizzazione degli studenti dell’estrema destra) e fondatori dei gruppi d’Aristocrazia Ariana che si ispirano alle tesi antisemite di Adolf Heichmann.
Lorenzon rilascia un resoconto dettagliato di una discussione che ebbe alcuni giorni prima della strage di Piazza Fontana dall’amico Ventura il quale gli confida di appartenere ad un’organizzazione clandestina responsabile di numerosi attentati compiuti nell’agosto del ’69 con l’obbiettivo di creare il terreno favorevole ad un colpo di stato mirante ad instaurare un regime ispirato alla Repubblica di Salò.
I magistrati di Treviso ritengono di avere sufficienti informazioni per aprire un inchiesta che segua la cosiddetta pista nera. Nel frattempo Valpreda sconta la propria condanna in carcere. L’inchiesta dei magistrati di Treviso compie una svolta decisiva nel novembre 1971, quando si scopre per caso un arsenale di munizioni NATO presso l’abitazione di un esponente veneto di Ordine Nuovo. Tra le armi ritrovate sono presenti delle casse metalliche di marca Jewell: le stesse utilizzate per contenere gli ordigni deposti in Piazza Fontana. Quell’arsenale era stato nascosto da Giovanni Ventura dopo gli attentati del 12 dicembre ’69. I magistrati scoprono inoltre che il gruppo neofascista teneva le sue riunioni presso una sala dell’Università di Padova messa a disposizione dal custode Marco Pozzan, anche lui esponente di O.N. Pozzan riferisce che il piano per gli attentati ai treni dell’agosto ’69 e quello contro il rettore ebreo dell’Università di Padova effettuato nello stesso periodo, aveva ricevuto il via libera in una riunione notturna tenutasi nell’aprile del ’69 con la partecipazione di un personaggio importante che avrebbe dovuto concedere il suo benestare; quel personaggio era il capo di O.N. nonché dirigente nazionale del MSI Pino Rauti. Il 3 marzo 1972 Freda, Ventura e Pino Rauti vengono arrestati con l’accusa di essere responsabili di numerosi attentati commessi tra l’aprile e l’agosto del ’69. Solo alcuni giorni più tardi si aggiungono ai capi d’imputazione gli attentati del 12 dicembre e i fascicoli sono trasmessi alla magistratura milanese, nelle persone dei giudici D’ambrosio e Alessandrini. La loro prima iniziativa è quella di rimettere in libertà Pino Rauti senza far cadere i capi d’accusa, ciò per evitare che se Rauti fosse eletto deputato, i fascicoli passassero di diritto ad una commissione parlamentare.
I magistrati Milanesi battono con grande sollecitudine la pista nera cominciando a cogliere elementi che provano i rapporti tra gruppi dell’estrema destra e apparati dello Stato; l’istruttoria verrà però congelata nel 1974 con la decisione della corte di Cassazione di sottrarre l’inchiesta ai magistrati milanesi.
Il fascicolo viene riaperto nel 1990 dal Pubblico Ministero Salvini. Nel frattempo Pietro Valpreda è rilasciato e la strage di Piazza Fontana resta senza mandanti né esecutori; Freda e Ventura sono condannati con sentenza definitiva per il reato di associazione sovversiva e per gli attentati dell’agosto 1969, mentre vengono assolti per insufficienza di prove per i cinque attentati del 12 dicembre.
Ribattendo nuovamente la pista nera, Salvini torna a dare un nome ai responsabili della strage: l’uomo che il 12 dicembre 1969 depone la bomba presso la Banca Nazionale dell’Agricoltura è Delfo Zorzi, militante nella cellula veneziana di Ordine Nuovo ai comandi di Carlo Maria Maggi. Zorzi dopo l’attentato riparò in Giappone dove tuttora vive protetto dal governo Nipponico che ha sempre rifiutato di concedere l’estradizione del neofascista.
Zorzi nonostante ancora nel 1987 fosse segnalato come “persona pericolosa per la sicurezza dello stato”, ebbe modo di rifugiarsi oltre oceano grazie ad un passaporto diplomatico concessogli dal Ministero degli Esteri Italiano, per la sua attività svolta in favore del Giappone. Attività che consisteva in una collaborazione attiva con le autorità nipponiche allo smantellamento della Japan Red Army, un gruppo armato di estrema sinistra, equivalente alle Brigate Rosse Italiane. Alcuni anni più tardi, la fuga di Zorzi, così come quella di altri neofascisti implicati nella strage di Piazza Fontana, fu scoperto essere stata progettata dal generale Maletti e dal suo vice, il capitano La Bruna, responsabili dell’ufficio D del S.I.D.; questi ultimi furono poi arrestati ed accusati non solo di aver favorito la fuga dei terroristi, ma di aver per anni intessuto una rete di rapporti continuativi con gli stessi, rifugiati all’estero.
Inoltre Zorzi era stato già precedentemente arruolato dal questore Elvio Catenacci, nell’ambito dell’attività anticomunista svolta dall’ufficio affari riservati del Ministero degli Interni. D’altro canto fu proprio il Ministero dell’interno con la supervisione di James Angleton, ufficiale della NATO in Italia, che organizzò l’operazione di infiltrazione di esponenti dell’estrema destra nei principali gruppi politici della sinistra, con il chiaro obbiettivo di far ricadere su questi ultimi la responsabilità degli attentati dinamitardi effettuati in quegli anni. In questo senso è significativo il ruolo di Mario Merlino militante di Avanguardia Nazionale che tornato in Italia dopo un viaggio nella Grecia dei Generali fascisti, condotto insieme a Pino Rauti, si converte all’anarchismo, fondando il circolo 22 Marzo, nelle cui fila andranno a militare proprio quegli elementi che Merlino indicherà come responsabili della strage di Piazza Fontana.
Il programma di infiltrazione nei movimenti dell’estrema sinistra rientra in una strategia più ampia, che fu definita con grande precisione in un documento elaborato da Ordine Nuovo nel maggio 1965 ad un convegno presso l’Hotel Parco dei Principi, presieduto da un generale dei paracadutisti e dal presidente della Corte d’Appello di Milano a cui partecipò il fior fiore dell’estrema destra italiana. Questo documento fu rinvenuto a Lisbona nel 1974 presso la sede di Aginter-Presse, un’agenzia diretta dall’ex ufficiale dell’OAS (il gruppo terroristico neofascista Algerino formato da paramilitari Francesi che si opposero con ogni mezzo contro l’indipendenza dell’Algeria) Guerin Serac e da Robert Leroy ex ufficiale delle SS-Waffen in Francia; un’agenzia che nascose per molti anni la più importante centrale neofascista europea a cui facevano riferimento i principali gruppi eversivi di tutta Europa, Franchisti e Greci compresi. Il documento in questione esprime con grande precisione i termini di quella che anni dopo sarà ricordata come la “strategia della tensione”. Si fa riferimento in particolare alla necessità di favorire lo stabilirsi del caos, minando l’economia dello stato affinché si determini confusione in tutto l’apparato legale. Questo produrrebbe una situazione di forte tensione politica, di avversione verso il governo e tutti i partiti; la prima azione da scatenare consisterebbe nella distruzione delle strutture dello stato, attraverso i gruppi comunisti e filo-cinesi guidati da appositi elementi infiltrati. Ciò crea un sentimento di avversione nei confronti di coloro che saranno ritenuti responsabili di questo clima di tensione. A partire da questo stato di fatto si dovrà rientrare in azione nel quadro dell’esercito, della chiesa e della magistratura per agire sull’opinione pubblica indicando una soluzione politico economica adeguata al momento. Il nuovo organismo politico dovrà quindi apparire come difensore dei cittadini e unica alternativa al terrorismo comunista dilagante.
Il 12 dicembre 1969 rappresenta il punto cruciale di questa strategia, il detonatore che dovrebbe far saltare definitivamente le Istituzioni Repubblicane, attraverso la proclamazione dello stato d’emergenza. I promotori politici e gli esecutori di questo fallito golpe vanno dai fanatici neonazisti come Valerio Borghese (ex comandante della X MAS) ai socialisti moderati come Saragat, tutti quanti accomunati da un forte sentimento anticomunista. La sera dell’11 dicembre si riuniscono a Milano quadri dei servizi segreti, alti ufficiali dell’esercito e supervisori della NATO, allo scopo di definire i termini ultimi dell’intervento militare dopo la proclamazione dello stato d’emergenza; la mattina del 12 Dicembre si segnalano attorno alla capitale movimenti di truppe e carri armati. Dopo la notizia degli attentati di Milano e Roma il piano prosegue secondo copione e il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat invoca lo stato d’emergenza ma trova un ostacolo inaspettato nell’ostilità del Presidente del Consiglio Rumor e del Ministro del lavoro Donat Cattin, entrambi spaventati dalla reazione suscitata e dall’enormità dell’evento.
Gli uomini politici della strategia golpista avevano d’altro canto l’idea di un colpo di stato che fosse più simile a quello che in Francia, nel 1958, portò al potere il Generale De Gaulle, mentre ben presto si resero conto d’essere sopraffatti dall’estrema destra, che si muoveva invece seguendo il modello del golpe militare con cui i colonnelli Greci si impadronirono del potere nel 1967. Aldo Moro incontrò Saragat il 23 dicembre e si impegnò a coprire tutto in cambio della rinuncia a posizioni oltranziste sullo stato d’emergenza (secondo dichiarazioni dello stesso Moro, rievocate in un memoriale ritrovato poi nel covo delle BR in via Montenevoso a Milano). Il fallito golpe lasciò sulla Piazza 16 morti e centinaia di feriti nella sola giornata del 12 dicembre 1969.
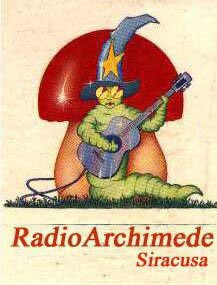 |